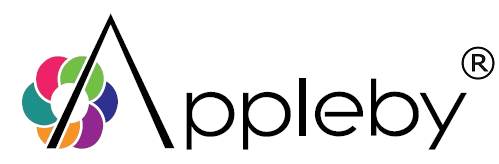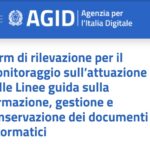Il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare dell’intelligenza artificiale generativa, non può essere ridotto a una sterile contrapposizione tra apocalittici e integrati. Come Centro Studi dedicato al pensiero di Paul H. Appleby, riteniamo che la questione centrale non sia se sviluppare queste tecnologie, ma come governarle per servire l’interesse pubblico.
Il recente caso emblematico riportato dalla stampa (Corriere della Sera, 30 ottobre 2025), relativo alla decisione di Amazon di tagliare 30.000 posti di lavoro “white collar” (colletti bianchi) entro il 2026 proprio a causa dell’evoluzione dell’IA, non è un semplice fatto di cronaca aziendale. È il sintomo di una rivoluzione strutturale che tocca il cuore della nostra organizzazione sociale ed economica.
Ciò che desta preoccupazione è che, di fronte a segnali così profondi, i mass media e l’opinione pubblica appaiono spesso distratti, concentrati sul sensazionalismo della nuova tecnologia piuttosto che sulle sue conseguenze amministrative e politiche. Questa disattenzione al come governare il cambiamento è forse il problema più grande, poiché lascia che decisioni di portata storica vengano trattate come mere questioni tecniche o private.
Il nostro approccio a questa sfida si fonda su tre pilastri derivati dal pensiero di Appleby.
Paul H. Appleby ha tracciato una distinzione fondamentale tra l’amministrazione privata e l’amministrazione pubblica. La prima è legittimamente mossa da logiche di profitto ed efficienza interna (come nel caso Amazon o nella trasformazione di OpenAI in entità for-profit). La seconda, l’amministrazione pubblica, risponde a un orizzonte più vasto: quello della responsabilità democratica e della tutela del benessere collettivo. L’ottimizzazione di un processo aziendale tramite IA è una scelta privata; la gestione di 30.000 nuovi disoccupati qualificati e la ridefinizione del mercato del lavoro sono una questione eminentemente pubblica. Confondere questi due piani significa abdicare al ruolo della governance democratica.
Appleby sosteneva che le decisioni amministrative di rilievo non sono mai tecnicamente neutrali; sono intrinsecamente “politiche”, nel senso che implicano una scelta tra valori e interessi concorrenti. Applicare questo concetto all’IA è cruciale. La scelta di quali dati usare per addestrare un algoritmo, di quali settori automatizzare per primi (oggi i ruoli strategici e di supporto, non solo la logistica) e di come ridistribuire i guadagni di produttività non è una decisione tecnica: è una decisione politica con vincitori e vinti. Come dimostra il caso Amazon, l’efficienza per l’azienda si traduce in un costo sociale (l’esternalità della disoccupazione) che la collettività deve assorbire.
Di fronte a sfide di vasta portata, Appleby invocava una “Big Democracy”: un’amministrazione pubblica robusta, trasparente e capace di affrontare la complessità. Oggi, di fronte a una “Big Tech” che agisce su scala globale, questa necessità è ancora più urgente. Non si tratta di frenare l’innovazione, ma di incanalarla. Lo Stato e le istituzioni pubbliche non possono essere spettatori passivi. Hanno il dovere etico e politico di:
- Regolamentare: definire i confini etici e legali (trasparenza algoritmica, responsabilità, protezione dei dati) entro cui l’IA può operare.
- Mediare: gestire le transizioni occupazionali, investendo massicciamente in reskilling e creando nuove forme di ammortizzatori sociali adatti non più solo ai lavoratori manuali, ma anche ai “colletti bianchi” e ai professionisti.
- Orientare: utilizzare la leva pubblica (investimenti, appalti) per dirigere lo sviluppo dell’IA verso la soluzione di grandi problemi collettivi (sanità, clima, istruzione) e non solo verso l’ottimizzazione del profitto privato.
Il caso Amazon è l’avvisaglia di un cambiamento che mette in discussione il patto sociale. La tecnologia non è un destino; è uno strumento. La posizione del nostro Centro Studi, fedele all’eredità di Paul H. Appleby, è che il valore ultimo di questo strumento non debba essere misurato solo in termini di efficienza economica, ma in base alla sua capacità di promuovere l’equità, la stabilità sociale e l’interesse pubblico.
La sfida etica non è tecnologica, ma di governance.