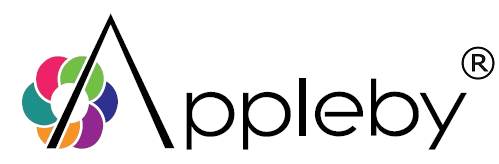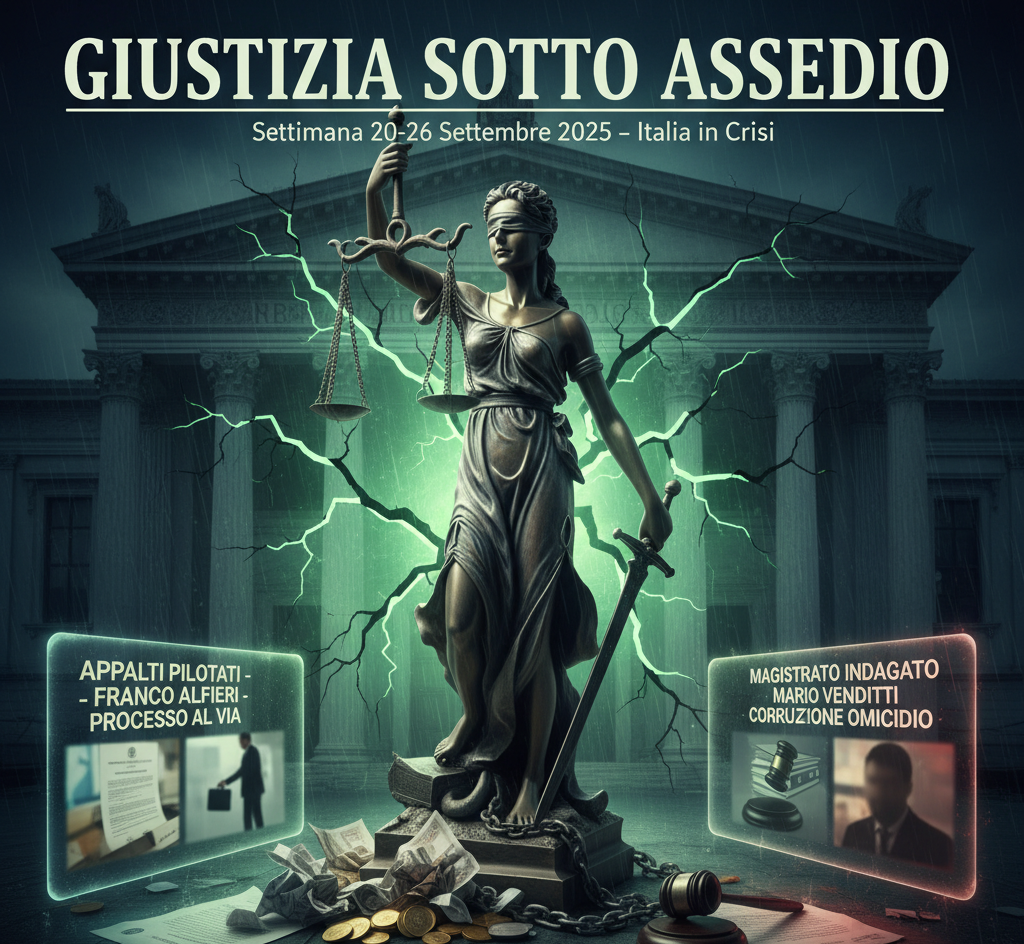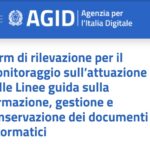Giustizia sotto assedio: appalti pilotati e magistrati indagati.
Una Settimana critica per la legalità in Italia
La settimana compresa tra il 20 e il 26 settembre 2025 si è imposta all’attenzione nazionale come un momento di profonda crisi per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni italiane. Due vicende giudiziarie distinte, ma convergenti nel loro impatto corrosivo, hanno dominato la cronaca: l’avvio del processo per appalti pilotati a carico dell’ex potente politico salernitano Franco Alfieri e, con un’eco ancora più inquietante, l’apertura di un’indagine per corruzione a carico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, in relazione a uno dei casi di omicidio più mediatici del Paese. Questi eventi non rappresentano semplici episodi di cronaca, ma si configurano come sintomi di una duplice patologia: da un lato, la corruzione endemica nella gestione degli appalti pubblici locali; dall’altro, una sfida senza precedenti all’integrità stessa del potere giudiziario.
Questa ondata di scandali emerge in un contesto istituzionale apparentemente impegnato nella lotta alla corruzione. Proprio in questo periodo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è impegnata in iniziative di alto profilo, come la consultazione pubblica per il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2025-2027” e il “Piano Nazionale Anticorruzione 2025”. Tali sforzi burocratici, volti a rafforzare i concetti di “Valore Pubblico” ed “Etica Pubblica” come pilastri della buona amministrazione , appaiono in stridente contrasto con la sfrontatezza delle condotte criminali ipotizzate. La concomitanza di questi due scandali, uno amministrativo e l’altro giudiziario, non è un fatto casuale, ma genera un effetto sinergico devastante. Il caso Alfieri conferma il diffuso sospetto che la politica locale sia incline a manipolare le risorse pubbliche per interessi privati. Il caso Venditti, tuttavia, attacca una convinzione più fondamentale: l’imparzialità del sistema giudiziario, ultimo baluardo contro l’illegalità. Quando entrambe queste narrazioni negative trovano conferma simultaneamente, il risultato è un crollo della fiducia sistemica. Il pubblico è portato a credere non solo che l’amministrazione sia corrotta, ma che il meccanismo stesso designato a punire tale corruzione sia, a sua volta, in vendita. I due casi, pertanto, espongono collettivamente profonde vulnerabilità nel sistema italiano, sollevando interrogativi critici sull’efficacia dei controlli esistenti e sulle fondamenta stesse dell’autorità legale e amministrativa.
Capitolo 1: Il Processo Alfieri – Anatomia di un presunto sistema di potere nel Salernitano
1.1 Si apre il sipario a Vallo della Lucania
Il 25 settembre 2025, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, si è tenuta la prima udienza del processo a carico di Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno, e di altri sei co-imputati. L’apertura del dibattimento segna un punto di svolta in un’inchiesta che ha scosso il panorama politico campano. La scelta della sede non è casuale: il processo è stato trasferito da Salerno dopo che la difesa ha sollevato con successo un’eccezione di incompetenza territoriale, accolta dai giudici.
1.2 La rete del potere: attori e accuse
Al centro del dibattimento vi è la tesi della Procura, secondo cui Alfieri avrebbe agito come vertice di un’associazione finalizzata a manipolare gare d’appalto pubbliche. Le accuse principali sono di corruzione e turbata libertà degli incanti (comunemente nota come turbativa d’asta). Nello specifico, l’inchiesta si concentra su due appalti per l’adeguamento e l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Capaccio Paestum, che sarebbero stati “pilotati” per garantire l’aggiudicazione a una società predeterminata, la Dervit Spa. L’operazione della Guardia di Finanza ha portato anche al sequestro di beni per un valore superiore a 543.000 euro.
1.3 Il Modus Operandi: come “blindare” un appalto pubblico
L’inchiesta, basata su intercettazioni telefoniche e sull’analisi di documenti informatici, ha svelato un presunto modus operandi che va oltre la semplice corruzione, configurandosi come un caso emblematico di “cattura amministrativa”. Secondo gli inquirenti, il processo di gara pubblica sarebbe stato completamente svuotato di significato. La Dervit Spa, l’azienda destinata a vincere, avrebbe materialmente redatto gli atti di gara, inclusi i capitolati tecnici, molto prima che le procedure fossero ufficialmente indette. Questo significa che non si trattava di influenzare una gara, ma di scriverne le regole per garantirsi la vittoria. Il soggetto privato non si limitava a partecipare al gioco, ma ne dettava le condizioni all’arbitro pubblico.
1.4 Ripercussioni politiche e giudiziarie
Le conseguenze dell’inchiesta sono state immediate e profonde. In seguito alla conferma degli arresti domiciliari da parte della Cassazione, Franco Alfieri ha rassegnato le dimissioni da sindaco e, di conseguenza, da presidente della Provincia. In una dichiarazione pubblica, ha motivato la sua scelta con la necessità di non condizionare l’attività degli enti amministrati mentre si difende nel processo, dicendosi certo che “il tempo saprà restituire la verità”.
Capitolo 2: Terremoto sul caso Garlasco – Quando l’inquirente diventa l’indagato
2.1 Svolta a Brescia: L’Ex Procuratore Venditti nel mirino
Il 26 settembre 2025, un vero e proprio terremoto giudiziario ha scosso l’Italia. Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, oggi in pensione e presidente del Casinò di Campione d’Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. L’ipotesi accusatoria è di una gravità inaudita: Venditti avrebbe ricevuto una tangente dalla famiglia di Andrea Sempio per archiviare, nel 2017, l’indagine a carico di quest’ultimo per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. L’accusa colpisce al cuore l’imparzialità della giustizia in uno dei casi criminali più seguiti e dibattuti degli ultimi vent’anni.
2.2 Le prove chiave: Il “Pizzino” ed i flussi di denaro
L’inchiesta per corruzione è scaturita da elementi emersi durante le nuove indagini sull’omicidio Poggi. L’elemento centrale è un appunto manoscritto, un “pizzino”, rinvenuto in un block notes durante una perquisizione a casa dei genitori di Sempio. Il testo, breve ma esplosivo, recita:
“Venditti / gip archivia X 20-30 euro”. Per la Procura di Brescia, la sigla “X” indicherebbe una moltiplicazione e la cifra si riferirebbe a una somma tra 20.000 e 30.000 euro, ovvero il prezzo della presunta corruzione.
A corroborare questo sospetto, gli investigatori hanno individuato una serie di movimentazioni finanziarie definite “anomale”, avvenute tra dicembre 2016 e giugno 2017, proprio mentre era in corso l’indagine su Sempio. L’analisi dei flussi di denaro ha rivelato:
Una serie di assegni per un valore complessivo di 43.000 euro emessi dalle zie di Andrea Sempio in favore del fratello, Giuseppe Sempio (padre di Andrea Sempio).
Successivi prelievi in contanti per un totale di 35.000 euro effettuati da Giuseppe e Andrea Sempio da quei fondi.
Un’intercettazione in cui Giuseppe Sempio parlerebbe della necessità di “pagare quei signori lì” con modalità non tracciabili, per evitare problemi.
2.3 Scontro di narrative: Le strategie difensive e le reazioni
Di fronte a un’accusa così infamante, le reazioni non si sono fatte attendere. Il legale di Mario Venditti ha definito l’impostazione accusatoria “surreale”, basata su “un solo rigo di un appunto, allo stato privo di autore”, e ha indirizzato una nota di protesta al Ministro della Giustizia. Venditti stesso ha negato fermamente ogni addebito, dichiarando di non aver “mai preso soldi da nessuno” e sostenendo che, sulla base degli elementi dell’epoca, avrebbe nuovamente chiesto l’archiviazione per Sempio.
2.4 Un Processo da riscrivere? L’ombra della revisione sul delitto Poggi
Le conseguenze dell’indagine su Venditti trascendono il singolo caso di corruzione e potrebbero innescare un effetto domino legale di portata storica. Se le accuse contro l’ex procuratore dovessero essere provate, ed una condanna dovesse passare in giudicato, si dimostrerebbe che un’indagine cruciale è stata deliberatamente insabbiata per proteggere un sospettato. Questo non è solo un reato contro la pubblica amministrazione; è la vendita del risultato stesso della giustizia. In questo scenario, il potere discrezionale del Pubblico Ministero, un pilastro del sistema giudiziario italiano, non sarebbe stato usato per perseguire la verità, ma sarebbe stato trasformato in una merce privata, venduta al miglior offerente per garantire l’impunità.
Una simile conclusione fornirebbe alla difesa di Alberto Stasi un argomento potentissimo per chiedere la “revisione del processo”. La legge italiana prevede questa possibilità quando emergono nuove prove che dimostrano che il condannato potrebbe essere innocente. La prova che un sospettato alternativo e credibile è stato illecitamente scagionato da un magistrato corrotto costituirebbe un elemento di novità dirompente. L’indagine su Venditti, quindi, non è solo un caso di cronaca, ma un potenziale “terremoto legale” che potrebbe retroattivamente invalidare una delle sentenze più importanti degli ultimi decenni, costringendo il sistema giudiziario a confrontarsi con la possibilità agghiacciante di aver condannato un innocente mentre il vero colpevole veniva protetto da un servitore corrotto dello Stato.
Fiducia Istituzionale e la sfida permanente alla Legalità
I casi Alfieri e Venditti, emersi con forza nella stessa settimana, rappresentano le due facce di una medesima, profonda crisi di legalità. Il primo esemplifica la corruzione nella sfera amministrativa: la gestione delle risorse pubbliche piegata a un sistema di favori e guadagni illeciti. Il secondo incarna la corruzione nella sfera giudiziaria: la perversione del dovere più sacro dello Stato, quello di amministrare la giustizia in modo imparziale. Insieme, questi due eventi dipingono il quadro di un sistema in cui né gli amministratori dei fondi pubblici né i custodi della legge sembrano immuni alla tentazione dell’illegalità.
L’impatto cumulativo di questi scandali sul rapporto tra i cittadini e lo Stato è devastante. Essi erodono l’ “Etica Pubblica” di cui parlano i documenti programmatici e alimentano un cinismo che può tradursi in una minore adesione alle regole della convivenza civile, dalla conformità fiscale alla partecipazione democratica. Le iniziative di riforma, come quelle promosse dall’ANAC o quelle riguardanti lo status dei magistrati, pur necessarie, rischiano di apparire come meri esercizi procedurali se non accompagnate da un reale impegno per l’integrità e da meccanismi di controllo efficaci e indipendenti. La settimana del 20-26 settembre 2025 resterà come un monito severo: la legalità non è un dato acquisito, ma una sfida permanente che richiede vigilanza costante a ogni livello della Pubblica Amministrazione e della magistratura.